To Do: Scacchiera
Gli anni del Big Bang: 1957-66
Lo scenario che si delinea alla metà degli anni Cinquanta è
sensibilmente diverso da quello del mondo dopo la Seconda guerra mondiale. Nel
1956 gli addetti al settore terziario superano per la prima volta negli Stati
Uniti i lavoratori dell’industria e dell’agricoltura messi insieme. Inizia una
modifica dell’intera società. L’arte, in generale, è sempre più legata
all’attualità della vita di tutti i giorni e all’emergere delle nuove opportunità
e problemi legati alla società di massa.
Il duro Espressionismo viene sostituito nella seconda parte
degli anni Cinquanta con ricerche che si denomineranno “pop”, popolari. La
nuova società è composta da grandi artisti quali A. Warhol, R. Lichtenstein o
C. Oldenburg. In Italia a Burri segue M. Rotella che scortica i manifesti dei
film che si sovrappongono l’uno all’altro. Questo nuovo mondo, basso e
quotidiano diventa un nuovo soggetto a cui gli artisti danno voce e forniscono
una ribalta. In Francia, nel 1957 si fonda l’Internazionale e Y. Friedman fonda
il Groupe d’Etude d’Architecture Mobile dove i progetti erano basati sulla
trasportabilità delle strutture.
In Gran Bretagna un gruppo di giovani pubblica nel 1961, la
rivista “Archigram” che ibrida diversi generi è simbolo di una nuova
generazione che emerge e crea un nuovo linguaggio. Le proposte di sei
Architetti si basano su una tecnica che è simbolo della società contemporanea:
il collage. Il collage viene riproposto anche in architettura con Growan e J.
Stirling che creano nell’Università di Leicester un’opera che assembla il
patrimonio degli architetti della generazione precedente.
La particolarità di questi anni Sessanta è la nascita di un
atteggiamento di “esclusività”. Il
movimento che si attua in questi anni è antikaniano, è un’esplosione centrifuga
che frammenta il corpus unitario della disciplina in una miriade di eterogenei
punti frammentari. È il Big Bang dell’architettura. Prendono forma esperienze
puramente formalistiche che disprezzano un approccio costruttivo e tecnologico.
Le nuove città realizzate in seguito alla rivoluzione post-bellica
e il boom sono caratterizzate da edifici multipiano formate da cellule
identiche l’una all’altra, le case, le strade, gli spazi sono stati descritti
come entità separate, incapaci di determinare delle relazioni significative.
Constant sostiene che il problema risiede in almeno quattro considerazioni.
Innanzitutto, si rivela fallimentare l’dea della tabula rasa
e della contrapposizione programmatica tra il nuovo e il preesistente. Il secondo
limite è il procedere attraverso “problemi isolati”. Il terzo problema
risiedeva nella concezione spaziale. Lo spazio urbano era concepito come un
vassoio teoricamente illimitato, omogeneo in tutte le dimensioni, governato
dallo standard, dai rapporti tra volumi puri sotto la luce e in fondo non
importante in sé, ma solo come risultante dei volumi che vi poggiavano.
L’ultimo problema viene definito da Constant come ludico.
Sul finire degli anni Cinquanta, emerge una posizione più
forte e decisa di quella del Town design britannico ovvero quella della
“macrostruttura”, che prendeva spunto dai progetti degli anni Trenta di Le
Corbusier. L’architettura diventava città essa stessa e se l’architettura fosse
stata città, allora, sarebbe potuta dettare i rapporti con la natura, con il
paesaggio, con il già costruito. La dimensione dell’architettura non è più “il
quartiere” ma una vera e propria dilatazione territoriale e geografica della
sua presenza.
Nella seconda parte degli anni Cinquanta un gruppo di
architetti critica il modo di costruire le periferie del primo dopo guerra,
bisognava quindi basarsi su concetti che fossero in grado di proporre una nuova
forza e una nuova essenza della città contemporanea. Non deve esserci una
scissione tra piano urbanistico, i sistemi insediativi e il progetto e anzi i
progetti si devono porre in rapporto dialettico con il paesaggio naturale e con
i tessuti urbani preesistenti.
Negli anni 70 gli architetti incominciano ad avvicinarsi
alla corrente filosofica dello Strutturalismo che riconosce una relazione tra
sistemi e variazioni, tra strutture e pensiero. La dialettica regola-variazione
è una caratteristica di metodo comune al gruppo di architetti che aderisce al
Team X e trova in ciascuno una sua declinazione.
In Europa e negli Stati Uniti nel corso degli anni Sessanta
si afferma un modo di operare che rappresenta una critica al modello per case
alte isolate e immerse nel verde. La formula è quella del low rise-high density
che intende limitare le altezze ai tre o al massimo quattro piani sopraterra.
Il tema diventa quello della continuità che si concretizza attraverso la
definizione di una serie di spazi, all’interno e all’esterno del complesso che
valorizzano il contesto accettandone le regole di formazione. Il “tessuto”
diviene la parola chiave, si procede dal basso creando le trame entro le quali possono
ricadere le variazioni dello spazio. Il terreno diviene una sorta di mappa
modulata, un tappeto da progettare come un insieme di spazi. All’interno della
griglia si gioca la partita del progetto con una serie di variazioni.
Il successo dell’architettura nel mondo:
1988-2000
Nel 1988 a New York si apre la mostra dal titolo
Deconstructivist architecture, ispirata da P. Johnson e curatore M. Wigley.
La mostra presenta sette personalità ovvero P.Eisemann, Z.
Hadid, F.Gehry, C. Himmelblau, B. Tschumi, D. Libeskind e R. Koolhaas. Il
grande successo della mostra parte già dal titolo, in quanto il termine
decostruttivismo ha molti echi e assonanze. I curatori della mostra giocano sulla
contrapposizione Decostruttivismo e Costruttivismo, uno movimento artistico e l’altro
concetto filosofico.3° la parola allude all’arrivo di un nuovo stile. Johnson
sostiene che nel paese del business, il rinnovamento delle forme è necessario a
mantenere in tensione l’architettura e consentirle di aver peso nella società.
In questo periodo il mondo sta cambiando velocemente, in Russia
nel 1987 Gorbačëv proporrà l’dea di “ricostruzione” delle strutture economiche
che intende inserire nel sistema sovietico ma il processo gli sfugge di mano
provocando la liberazione dal sistema comunista dei paesi del blocco socialista.
Il 1989 è un anno fondamentale perché simboleggia la caduta del muro di Berlino
che ha avuto come conseguenza la dissoluzione dell’Unione Sovietica e l’inizio
di una nuova epoca. L’apertura dei blocchi porta a un cambiamento della carta
geografica e dei confini e da un’accelerazione alla globalizzazione dell’economia.
D. Libeskind è un architetto di nuovo stampo. Alla metà degli
anni Ottanta Libeskind è uno sperimentatore eccentrico, realizza una serie di
congegni a cui associa dei disegni astratti, una specie di partiture musicali
che lavorano sulla forza rappresentata dalla linea. Linee che creano micromondi
e un universo di costellazioni e di potenzialità. La realtà per Libeskind può
essere avvicinata solo come costante interconnessioni di processi, di sistemi,
di “strati”.
In questo nuovo clima, Zvi Hecker apre uno studio a berlino e costruisce a Duisburg una scuola capolavoro, che è metafora e allo stesso tempo sviluppo del tema paesaggistico in architettura.
Alyin Toffler sosteneva che dopo una fase dell’umanità
durata migliaia di anni e caratterizzata dal possesso della terra e dalla
produzione agricola e dalla fase di produzione industriale si stava definendo
una terza ondata caratterizzata dal possesso e dal ruolo dell’informazione. L’informazione,
spiega Toffler, è ciò che rende competitivo qualunque bene.
IL valore dell’architettura del nuovo secolo ricerca una
forma che appunto informa e che entra a far parte del grande mondo della
comunicazione contemporanea.
Gli anni 90 del Novecento vedono l’affermazione della
società “post-industriale” e due grandi questioni assumono rilevanza: la prima
era legata alle brown areas, ovvero estese aree svuotate dagli usi industriali.
La seconda questione ruota su una riconsiderazione dei rapporti
architettura-natura.
Una delle conseguenze della civiltà dell’informazione è il
ribaltamento del concetto di zoning. Lo zoning corrispondeva a una città
rigidamente divisa in tempi e spazi. Mentre la società dell’informazione si basa
sull’opposto. Attraverso l’impetuoso sviluppo delle reti di comunicazione, la
società dell’informazione, combina, sovrappone e intreccia le funzioni che
prima erano divise.
Lo sviluppo della società dell’informazione porta anche a
una concorrenza tra città che cercavano di attrarre sempre più residenti e
visitatori.
L’architettura non nasce più pura, nuova e sola ma si
incunea, rammaglia, attraversa ed è continuamente attraversata dal già presente.
Sul finire del secolo si assiste al passaggio dall’idea di
spazio organo alla concezione di spazio sistema. Per spazio organo si intendeva
lo spazio che si conformava in base alla funzione che doveva svolgere, come per
esempio avviene nel Museo Guggenheim di New York. L’idea dello spazio sistema
implica la creazione di un edificio che non sia basato sul funzionamento
interno ma su una maglia molto più complessa di scelte come, per esempio, vediamo
nel Museo Guggenheim a Bilbao. Si assiste a un processo di “liberazione” dell’architettura,
di sganciamento da ogni sistema preordinato gerarchicamente.
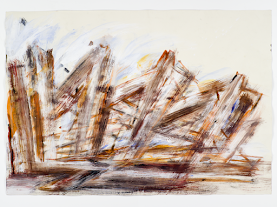

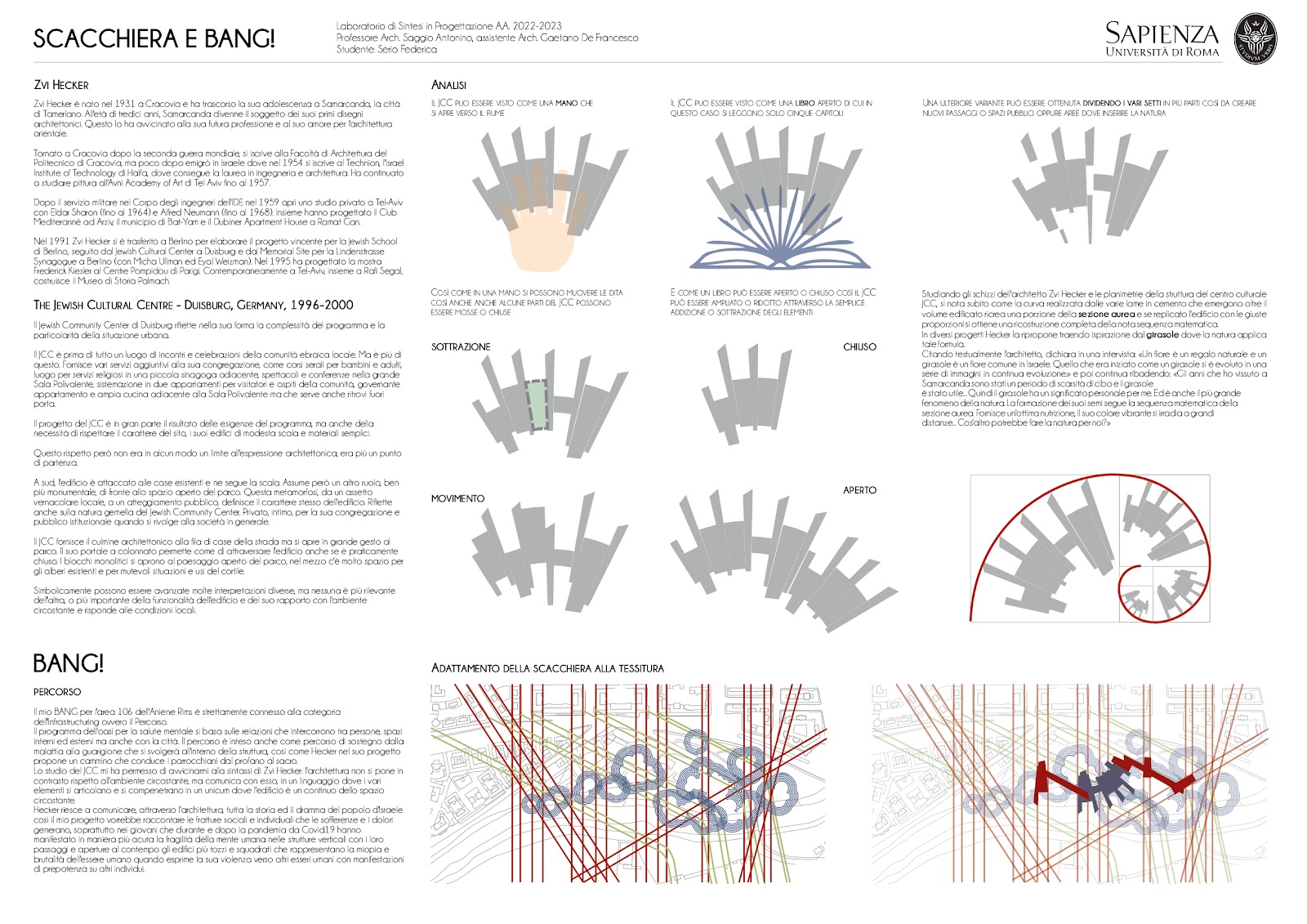


Commenti
Posta un commento